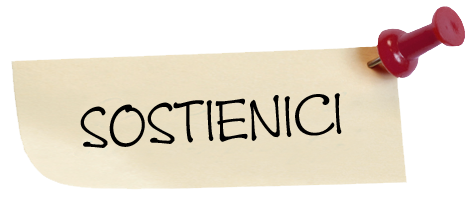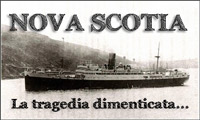1936: Un progetto organico di sviluppo socio-economico
del Corno d’Africa
Anche negli anni successivi alla amministrazione britannica, quelli della breve federazione e successiva unione con l’Etiopia, la comunità italiana, pur in situazione di incertezza e soggetta ad un lento costante stillicidio di partenze, seppe esprimere la propria creatività. E sarà l’ing. Barattolo a risollevare dalla rovina le piantagioni di cotone di Tessenei e a creare in Asmara un cotonificio, Camerino a riprendere e portare a compimento gli esperimenti rivolti a perfezionare la macchina per la defibrazione della foglia della palma dum, riattivare la raccolta e la macerazione nel bassopiano e creare lo stabilimento per la lavorazione della fibra, De Nadai a salvare dal deperimento le concessioni di Elaberet, valorizzandole con una diga e canalizzazioni, estendendo poi le coltivazioni in altre zone e aprendo propri centri di smercio di frutta e verdura nei vicini Paesi arabi. Con loro non possiamo non ricordare la STAR e l’ INCODE che riattivarono i centri per la lavorazione della carne in scatola, i Marazzani e gli altri nell’agricoltura e nell’allevamento di bovini da latte, Cipollini e Bini e Mereghetti nell’industria calzaturiera, Baldini – Perrone e Duca e Crescentini nell’industria conciaria, Gargano – Pannesi nell’industria laniera. Attività tutte, tranne la STAR e l’INCODE, a tutti gli effetti etiopiche ( o, se si preferisce eritree ), in quanto create con capitali locali, da persone da decenni residenti in una terra che consideravano una seconda patria, con utili che non andavano all’estero ma venivano reinvestiti nel territorio. Alla luce di queste considerazioni le nazionalizzazioni decise negli anni settanta dal governo rivoluzionario etiopico ( in dispregio alla politica lungimirante dell’imperatore Hailè Selassiè ) risultano solo patetiche manifestazioni di un malinteso nazionalismo. D’altronde in ciò l’Etiopia non faceva che seguire l’esempio della grande maggioranza delle ex-colonie africane e non, che non si rendevano conto che con tali decisioni avrebbero precluso ai loro Paesi l’arrivo di capitali dall’estero per eventuali investimenti. Cosa che si è puntualmente verificata e che ci riporta al punto di partenza.

Vivaio di Caffè a Becacsà nel Hararino fra i monti Cercer e Gugù, realizzato da una grande società italiana cui era stata assegnata in concessione una estesa superficie da adibire a piantagioni di caffé.

Giovane impianto di tè nei pressi di Bonga (Galla Sidamo) curato dalla Missione della Consolata.


Sull’altipiano degli Arussi, nei pressi di Aselle, una grande società con fini di allevamento aveva introdotto ovini pregiati da allevare in purezza ed in incrocio con quelli locali. Contemporaneamente aveva avviato coltivazioni di cereali ed altre piante alimentari e prove per la coltura del piretro. Nelle foto: espetti della zona con un gruppo di pecore Remmay Marsh ed un campo di piretro.
Da decenni ormai gli unici investimenti nell’Africa sub-sahariana (escluso, almeno fino ad ora, il Sud-Africa) sono solo in infrastrutture e non in attività produttive. In altre parole non si produce ricchezza, anzi questa diminuisce vuoi per il degrado di quanto a suo tempo creato, vuoi per il venir meno del mercato costituito dalla presenza europea, vuoi perché le popolazioni cercano rifugio nelle attività ancestrali e al ritorno nella tribù o nella stirpe, unica speranza di fronte all’instabilità del presente e all’incertezza del futuro. Anche in quei Paesi, come la Nigeria, l’Angola e pochi altri dove si sono scoperti il petrolio o altre fonti economiche, la ricchezza che ne proviene si perde in nemmeno tanto misteriosi rivoli, e non solo non diffonde i suoi benefici sulla massa della popolazione, ma nemmeno si trasforma in investimenti per nuove iniziative. I Paesi africani diventano ogni anno che passa sempre più dipendenti dall’estero perfino per le derrate alimentari; mercati potenziali, quali i paesi arabi, che potrebbero costituire interessanti sbocchi per i prodotti ortofrutticoli, vengono perduti, … un mio amico appena rientrato dalla penisola arabica dove si era recato per affari, mi ha detto che Dubai, il Baharein, l’Arabia e gli emirati sono invasi di frutta e verdura di provenienza sud africana. Pensare che De Nadai aveva aperto il suo primo magazzino a Gedda per i prodotti eritrei ancora negli anni 50/60 e un altro centro a Dubai (credo tutt’ora attivo e diretto da Claudio Covezzi) è operativo da almeno venti anni.
Le realizzazioni di Barattolo, Camerino, de Nadai ed altri in Eritrea, della società etiopica-olandese a Uongi e della Navigatana in Etiopia, confermano della validità dei progetti all’epoca elaborati.

Azienda di Bolè. Gregge di pecore del Mens, razza locale dell’altopiano, oggetto di miglioramento con la selezione.

La necessità della sperimentazione per risolvere problemi agrari vecchi e nuovi era apparsa subito all’attenzione del Governo italiano. Sin dallo stesso 1936 era stata costituita nei diversi ambienti del paese una serie di aziende agrarie sperimentali la cui azione era coordinata dal Centro Sperimentale Agricolo e Zootecnico per l’A.O.I., con sede sull’altopiano scioano a Bolè, nelle vicinanze di Addis Abeba. Nella foto le prime costruzioni ed alcune parcelle sperimentali dell’azienda di Bolè

Azienda di Mohammed Alì (altopiano scioano). Sistemazioni antierosive a terrazzo.
Si trattava di un programma a lunga scadenza e che solo dopo anni di studi, di esperienze e di duro lavoro avrebbe potuto esprimere appieno le sue potenzialità. Probabilmente alcuni progetti si sarebbero rivelati non perseguibili o la loro realizzazione non economicamente opportuna; le costosissime ricerche minerarie non rispondere alle attese, ecc… come sempre sarebbe stata la realtà ad imporre le sue regole e l’esperienza a suggerire le direttive per il futuro. Certo è che mai prima di allora, nella storia del colonialismo, si era tentato e dato avvio ad un programma così radicale di trasformazione di un territorio e mai uno Stato aveva destinato ad una propria colonia le risorse finanziarie che l’Italia aveva messo a disposizione per il programma medesimo.
Un programma certamente ambizioso ma che aveva elementi assolutamente innovativi rispetto ai processi economici messi in essere dalle altre potenze coloniali. Non possiedo la competenza e tanto meno la “ forma mentis “ dell’economista, ma a buon senso mi sembra di poter indicare tra questi:
1) la globalità. Si studiano e si promuovono iniziative in tutta la sfera economica: agricoltura, allevamento, ricerca mineraria, industria edile e quella di trasformazione, pesca, commercio, chimica ( l’industria per gli esplosivi, ad es. ma si pensava già per il futuro di riattivare l’attività di estrazione della potassa di Dallol sia per gli esplosivi che quale fertilizzante ) ecc…;
2) la compartecipazione. E’ previsto l’investimento capitalistico nelle colture monetarie (cotone, zucchero, ecc…), ma nello stesso tempo si incentiva l’agricoltore indigeno a diversificare le proprie colture, garantendogli assistenza tecnica e sostegno nella commercializzazione del prodotto;
3) la distribuzione delle iniziative pilota su tutto il territorio: i quattro distretti cotonieri in quattro regioni diverse, l’allevamento ovino negli Arussi, quattro oleifici in quattro città lontanissime tra loro, così era previsto per i cementifici, per gli allevamenti bovini, la coltura del te, del riso e così via. Fin da subito si intuisce come presente fosse nei pianificatori la volontà di garantire ai sei governatorati altrettanti poli economici, evitando quanto vedremo poi succedere in quasi tutte le ex colonie una volta raggiunta l’indipendenza, ossia l’accentramento di tutte le attività industriali e commerciali nella sola capitale, trasformata spesso in una megalopoli con periferie affollate di diseredati. A tutto discapito degli altri centri, condannati ad un lento declino.
4) la compattezza territoriale. L’unificazione del territorio consentiva l’elaborazione di programmi non più nel ristretto ambito dell’Eritrea o della Somalia ma su tutta un’area che presenta una notevole compattezza. Si consideri la razionalità prevista per la rete stradale; la grande utilità di poter intervenire, con bacini artificiali, chiuse ed altre soluzioni tecniche nel regolamentare l’afflusso delle acque del Giuba e dello Scebeli. Il controllo dei fiumi inizia dalla fonte; dighe e canali avrebbero procurato alla zona etiopica l’acqua per sviluppare il potenziale nell’agricoltura e nell’allevamento, mentre avrebbe garantito alla Somalia il controllo delle alluvioni stagionali ed altresì un regolare afflusso di acqua anche nella stagione secca.
Quest’ultimo elemento porta inevitabilmente al presente. Al riguardo mi limito ad una sola riflessione.
Nell’ottica dell’amministrazione italiana considerare quei territori un “ unicum “ era la struttura portante sulla quale si sosteneva tutta la costruzione della nuova realtà nata dalla conquista dell’Etiopia. Un unicum non solo con riferimento al territorio, ma anche per quanto riguardava le popolazioni, diverse per etnie, lingue, religioni, ma unificate nel comune status giuridico di sudditi, con una comune legislazione penale, identiche opportunità scolastiche, pari opportunità economiche, unite in un comune progetto di sviluppo socio-economico. Venuto meno il potere centrale che garantiva il perseguimento del progetto, le antiche divisioni presero il sopravvento. Sono seguiti sessant’anni di guerre e rivolte, fino alla situazione attuale ( meglio precisare la data - maggio 2007- perché quanto scrivo ora verrà pubblicato su Mai Taclì fra circa un anno ), che vede un intervento armato dell’Etiopia in Somalia a sostegno di una delle parti belligeranti, e un armistizio in atto tra Eritrea e l’Etiopia.
Vi è poi un’ altra ottica alla quale possiamo sottoporre quell’esperienza. Essa consiste nel porre a confronto il programma di allora per il Corno d’Africacon i saltuari, occasionali, interventi attuati dai Paesi industrializzati o dagli organismi internazionali nei 50/60 anni del dopo-colonialismo, a favore delle ex colonie africane e asiatiche. Parlare di fallimento forse è eccessivo, ma è comunque indubbio che i risultati sono minimi se rapportati alle risorse finanziarie in essi investite. I prestiti, le aperture di credito,ecc…, ad altro non sono serviti che a sostenere le spese correnti, ossia garantire stipendi e prebende alle uniche strutture organizzate, esercito e pubblica amministrazione, abbandonando a se stesse le masse contadine e quelle dei derelitti che si riversano nelle periferie delle capitali nella vana, disattesa speranza di una opportunità di lavoro.
Forse è arrivato per i Paesi industrializzati il momento di “ rivedere” tutta la politica finanziaria nei confronti dei così detti Paesi in via di sviluppo, vincolando prestiti, aperture di credito, ecc… a precisi progetti economici e a serie garanzie a tutela dei privati investitori. Quanto al “ che cosa fare” buoni suggerimenti possono venire dall’esperienza del 1936 / 1941 nel corno d’Africa, con il che questa mia ricostruzione di un’esperienza passata non risulterebbe opera vana.
Un impegno che forse potrebbe essere ripreso oggi non più dalla sola Italia ma dalla Comunità Europea, per la quale l’assunzione di tale progetto potrebbe costituire un fattore capace di rafforzare il sentimento unitario sia all’interno che nella realtà politica internazionale. Il progetto di un mercato comune presentato e sostenuto finanziariamente dalla C.E.E. potrebbe costituire per i Paesi del corno d’Africa una soluzione dignitosa di rappacificazione e per quelle popolazioni una iniezione di fiducia e speranza per il futuro. Se poi i governanti si rivelassero insensibili alla mano tesa dall’Europa, ebbene ! che siano loro a giustificare il rifiuto ai loro popoli.
Mario Frizzo